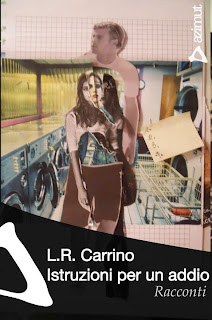Una trilogia nera
Alla fine del 1969, l’editore Eric Losfeld mandò in libreria la Trilogie noire, di Léo Malet. Era uno spesso volume che raccoglieva tre romanzi, i primi due già pubblicati una ventina di anni prima, il terzo inedito. Oggi, possiamo considerare la pubblicazione di quel libro, che si fregiava della sopracopertina di René Magritte, come un autentico avvenimento letterario. Vediamo perché.
Eric Losfeld era un editore sui generis, bersagliato dalla censura e dalla giustizia, la sua casa editrice si chiamava La Terrain Vague (“terreno abbandonato”, “terra di nessuno”: il nome, traduzione in francese del fiammingo “losfeld”, si doveva a una felice intuizione di André Breton) ed era una sorta di cenacolo post-surrealista nel quale si riunivano tutti coloro che, per un motivo o per un altro, parteggiavano l’entusiasmo di promuovere le culture marginali contemporanee: fumetti, cinema fantastico e horror, erotismo, fantascienza, realismo magico, poliziesco, noir. Fra gli altri, Losfeld aveva pubblicato i fumetti di Barbarella, riesumato i romanzi “maledetti” di Boris Vian, ed editava anche due riviste di cinema che si sarebbero fatte ricordare a lungo (“Positif” e “Midi-Minuit Magazine”). Era stato proprio il direttore di quest’ultima pubblicazione, Jean-Claude Rohmer, a interessarsi dell’opera di Léo Malet. Rohmer collezionava le pubblicazioni delle ricercatissime “Éditions du Scorpion” e non riusciva a trovare un titolo che gli risultava esservi stato pubblicato alla fine degli anni Quaranta: Sueurs aux tripes, di Léo Malet. Dopo tutta di una serie di ricerche vane, Rohmer si decise a contattare l’autore. Malet gli assicurò che il romanzo esisteva, solo che non era mai uscito di tipografia a causa della brusca chiusura della casa editrice: si trovava nell’elenco delle pubblicazioni ma di fatto era un testo fantasma. Rohmer ne parlò allora con Losfeld e l’idea di riunire La vie est déguelasse, Le soleil n’est pas pour nous e l’inedito Sueur aux tripes (che nel frattempo Malet aveva rititolato al singolare) in un’unica Trilogie noire era sembrata il più bell’omaggio che un editore stravagante come Losfeld potesse fare a un autore altrettanto eccentrico, dalla storia tutt’altro che lineare.
Ai tempi della pubblicazione della Trilogie noire, Léo Malet era già il maestro riconosciuto del poliziesco francese: il personaggio di Nestor Burma e la trentina di romanzi che ne raccontavano gli exploit costituivano ormai pagine gloriose di un genere letterario fortemente in voga in un paese che se n’è sempre (e non a torto) arrogato i natali. La Trilogie noire, pur avendo poco a spartire con il poliziesco in senso stretto, rinnovò l’attenzione sull’autore, ebbe un notevole successo di vendite, e oggi è considerata, insieme ad alcuni romanzi con Nestor Burma, il capolavoro di Malet, di certo l’opera che maggiormente ha influenzato la generazione di scrittori che ha iniziato a pubblicare fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta (Jean-Patrick Manchette, Pierre Siniac, Didier Daeninckx, Thierry Jonquet, Alain Demouzon, Marc Villard, Hervé Prudon, fra gli altri).
È singolare la fortuna del romanzo poliziesco francese. Indissolubilmente legato al feuilleton e alla serializzazione, ha sempre saputo creare personaggi in grado di resistere ai cambiamenti del gusto, dal Monsieur Lecoq di Emile Gaboriau fino al Fantômas di Pierre Souvestre e Marcel Allain, passando almeno per il Roulettabille di Gaston Leroux e l’Arsène Lupin di Maurice Leblanc, e proseguendo poi con il “naturalizzato” Maigret di Simenon e l’indemoniato Sanantonio di Fréderic Dard. Non solo, ma si è posto sempre il problema di mantenere costante il contatto con il lettore, anticipando in qualche modo il marketing editoriale, in cui eccellono oggi agenti e case editrici americane. Ogni personaggio, ogni collana, ogni autore doveva farsi trovare pronto all’appuntamento periodico con il chiosco o la libreria, ognuno tempestivo nello sfamare il proprio lettore (sfamare come solo sanno fare i libri, che non tolgono quel residuo di appetito…). Tanto che in una situazione di emergenza, quando cioè durante l’occupazione nazista venne istituito il divieto di tradurre opere di autori statunitensi, si concretizzò per chiunque avesse un paio di buone idee (anche di seconda o terza mano) e sapesse scrivere almeno decentemente la possibilità di accedere alla pubblicazione, sia pure con uno pseudonimo di secco sapore americano: Léo Malet fu della partita e macinò uno dopo l’altro una serie di romanzi di scuola hard-boiled che furono pubblicati a nome di firme fantasiose quali Frank Harding o Leo Latimer. L’esperienza fu oltremodo positiva, Léo Malet guadagnò qualche soldo e acquisì sul campo quella capacità di scrittura e di gestione della trama che gli permisero di fare velocemente il grande salto: pubblicare con i proprio nome romanzi polizieschi con protagonisti e ambientazioni francesi. Nacque così Nestor Burma, un personaggio che oltralpe avrebbe saputo gareggiare in popolarità, e spesso vincere, addirittura con il commissario Maigret.
Nonostante la notorietà acquisita (aveva già pubblicato sette inchieste di Burma, oltre a innumerevoli altri libri, quando uscì La vie est déguelasse), la scrittura di romanzi polizieschi non poteva appagare uno spirito inquieto come quello di Léo Malet. Era nato a Montpellier il 7 marzo 1909, e subito il destino non si era dimostrato affatto tenero con lui: quando aveva appena due anni aveva perduto a distanza di un paio di giorni il padre e il fratellino, e un anno dopo gli sarebbe morta anche la madre. Di lui, si era allora preso cura il nonno, un personaggio curioso, grande divoratore di libri, un appassionato più che un intellettuale, ma era stata l’influenza degli articoli di André Colomer, anarchico, pacifista e disertore della grande guerra, a incitarlo ad abbandonare, quando aveva appena sedici anni, la città natale per raggiungere Parigi, dove avrebbe vissuto alla giornata. Colomer aveva uno stile lirico e trascinante entro il quale riusciva a filtrare messaggi di violenza così espliciti da mettere spesso in imbarazzo i suoi stessi pur agguerriti compagni: cosa potessero istigare quelle parole nello spirito di un adolescente in credito con la sorte è facilmente intuibile. A Parigi, Colomer aveva subito introdotto il giovane Léo negli ambienti anarchici, regalandogli in qualche modo la famiglia che non aveva mai posseduto. Sei anni più tardi, nel 1931 la conoscenza di André Breton gli era valsa l’ingresso in un’ulteriore famiglia contigua con la precedente, quella dei surrealisti, oltre a un incitamento continuo alla scrittura (ma tutta l’esperienza surrealista di Malet andrebbe raccontata a parte, dai testi che produsse, agli incontri con Aragon e Prevert, fino alla censura che lo stesso Breton gli fece subire alla vigilia dell’Esposizione Internazionale del Surrealismo, nel 1938). Breton comunque non aveva dovuto insistere troppo e Malet non si era fatto pregare: scriveva, non faceva altro che scrivere. Le frequentazioni nell’ambito surrealista gli avevano fatto conoscere editori e redattori di case editrici: per tutti avrà un testo e uno pseudonimo, sia che si tratti di romanzi polizieschi, che di storie di pirati o di cappa e spada. Malet aveva la scrittura nel sangue (l’opera omnia raccolta qualche anno fa dall’editore Laffont consta di cinque volumi per un totale di quasi seimila fittissime pagine, ognuna delle quali contiene almeno tre volte tante parole di quelle del libro che avete tra le mani) ed era sempre alla ricerca di nuove frontiere, l’invenzione di Nestor Burma non gli bastava: sentiva che era venuta l’ora di scrivere anche il “suo” romanzo, questo La vita è uno schifo, il primo di quella che vent’anni dopo sarà conosciuta come Trilogia nera.
Qui, Malet procede per accumulo, unisce in un unico grande progetto letterario l’anarchismo della giovinezza, il surrealismo delle prime manifestazioni intellettuali e la scrittura poliziesca della maturità. Il tema dell’anarchismo lo si ritrova in alcune linee di pensiero del protagonista e nella riproposta del dibattito che animava il mondo anarchico parigino: quali armi per abbattere il potere? La violenza, il furto alla maniera di Jules Bonnot, o qualche strategia più moderna, che prescindesse dall’illegalità? È evidente che Malet, che dopo la conoscenza di Colomer aveva vagheggiato per se stesso un’esistenza da fuorilegge, è sedotto dalla prima ipotesi, anche se sa benissimo che i limiti fra violenza a scopo politico e violenza a scopo individuale sono così labili che lo sconfinamento prima o poi è inevitabile. Ma non c’è solo questo: Jean Fraiger, il protagonista, ha molti altri punti in contatto con l’autore. Il nome stesso, che ricorda quello della madre morta (Luise Refreger), la condizione di orfano, per non parlare di una concezione molto surrealista dell’amore (l’amour fou) che emerge nelle pagine centrali del romanzo. E che dire dell’idea, surrealista anche questa, ma già fortemente caratterizzata nel Marchese De Sade che siccome l’ordine è il male, non si può sfuggire dal male se non commettendo altro male, magari maggiore…
La vita è uno schifo, insomma, è un romanzo composito e sfaccettato: supera il romanzo poliziesco e apre la prospettiva di una scrittura e di tematiche diverse; di fatto canonizza un genere contiguo, il noir, con le sue scarne ma efficaci regole grammaticali.
Il noir, checché ne dicano alcuni critici di settore, non ha nulla a che vedere con l’hard-boiled school, la “scuola dei duri” americani formatasi intorno alla rivista “Black Mask”; in una parola il noir non ha nulla a che vedere con il poliziesco d’azione dei vari Hammett e Chandler (mentre in nuce traspare nei romanzi di James Cain, non a caso autore più amato dalla cultura europea, Visconti in testa). Il noir autentico è un romanzo psicologico intorno alla figura di una vittima, la scrittura del noir è sempre dal punto di vista della vittima, che si racconta o si fa raccontare nella propria discesa (o precipizio che dir si voglia) verso un punto di non ritorno. Nel giallo e nel poliziesco lo status quo viene frantumato da un evento imprevedibile di natura delittuosa, compito nella narrazione sarà di scoprire l’autore dell’infrazione, assicurarlo alla giustizia, ricomponendo così l’ordine iniziale. Che l’evento delittuoso sia un omicidio, un rapimento, un furto o una rapina, non ha importanza, così come non ne hanno l’identità (investigatore privato, poliziotto, detective dilettante) e il modus operandi di colui o coloro che si incaricano dell’indagine. Nel noir, invece, non c’è nessun ordine da ricomporre, non si torna mai al punto di partenza, l’ordine è un continuo frantumarsi in schegge impazzite di cui si perde il conto e la sostanza. Il romanzo poliziesco è un puzzle completo di tutte le proprie tessere: sarà sufficiente incastrarle le une nelle altre e il disegno apparirà in tutta la sua chiarezza. Nel noir il disegno è in continua evoluzione, ubbidisce a regole diverse, che possono cambiare da un momento all’altro. Per questo il noir non ammette lieto fine, o almeno l’unico lieto fine possibile è quando la vittima, conscia della propria condizione, si ribella e, attraverso una serie di atti “contro la legge” riesce a scamparla, a dettare le regole di un nuovo disegno, che avrà contorni, figure e colori del tutto differenti dal proscenio iniziale. In questo il noir è figlio del surrealismo e di De Sade: viviamo in un’epoca di male, e solo un male più forte può contrastarlo, cambiarne i connotati. Di qui il distacco finale, ancora più marcato, di fatto un’opposizione: nel romanzo poliziesco il male è un accidente, nel noir una costante; il primo ha una sostanziale attitudine rassicurante e consolatoria, il secondo è sempre eversivo.
Léo Malet e i poveri cristi
Abbiamo visto, parlando a proposito de La vita è uno schifo, come il noir sia, nella sua formulazione più genuina, il racconto dal punto di vista della vittima di un inciampo nella vita, uno scherzo del fato dal quale risulterà impossibile riprendersi. Quando questa sorta di caduta agli inferi avvenga, e in quali circostanze, non fa differenza, ed è materia del romanzo, come le reazioni della vittima al destino che gli ha travolto l’esistenza.
Può accadere anche – come in Il sole non è per noi – che questa caduta si sia verificata prima degli avvenimenti oggetto della narrazione, addirittura che esista da quando esiste il mondo, riassumendosi nell’impossibilità di uscire da una condizione disperante. Chi, per nascita, avesse a trovarsi fra le vittime della società, difficilmente potrebbe uscirne, potrebbe vedere la propria situazione migliorare. Qualsiasi sforzo riuscisse a produrre scatenerebbe sempre una forza contraria capace di rigettarlo al punto di partenza, se non addirittura più indietro, aprendogli le porte della prigione o anche indirizzandolo su una strada alla fine della quale c’è la morte certa.
Ed è proprio a partire da una convinzione di questo tipo che Léo Malet scrive il secondo tomo della Trilogia nera, Il sole non è per noi, offerto per la prima volta al pubblico nel 1949, un anno dopo La vita è uno schifo.
Il romanzo, ambientato poco più di vent’anni prima della data di pubblicazione (all’epoca della “gioia di vivere”, come segnala ironicamente l’autore in una nota posta in apertura), è la storia del giovane André Arnal, la cui breve esistenza è segnata dall’ombra costante della morte. Sin dalla sua nascita, una serie di eventi luttuosi lo hanno reso prima orfano, poi un “senza famiglia”. Non solo, lui stesso diventerà un portatore di morte, anche in modo del tutto involontario, casuale. Per niente imprevedibile sarà invece la fine del racconto, che chiude l’implacabile circolarità della struttura narrativa. Che è poi specchio dell’altrettanto implacabile struttura dell’esistenza, riflessa nella forte chiave surrealista.
Infatti, come nel precedente La vita è uno schifo, anche ne Il sole non è per noi l’impronta bretoniana è evidente e non sottacibile. Il lungo sogno di André Arnal verso la metà del libro ne è la dimostrazione più lampante. E la passione, l’amour fou, fra gli adolescenti André e Gina è così totalizzante e disperata, primitiva nella sua animalesca sensualità, che non può che riportare alla mente l’analogo, folle sentimento di Jean Fraiger per la conturbante Gloria. E non è un caso se, nel filo della narrazione, il rapporto fra i due ragazzi finisce per diventare il motore della storia e il principio di disgregazione della storia stessa. Eros sempre va a braccetto con Thanatos, e all’amore non è concesso niente più che un’illusione di riscatto.
Anche qui, insomma, la preoccupazione di Malet non sembra essere sociale (come pure potrebbero far pensare alcuni capitoli posti all’inizio del romanzo) quanto letteraria. La tensione e la rivolta non sono quelle dei personaggi, per i quali il destino ha già scritto la parte, quando dell’artista che, raccontandoli, tuffandosi in questo mondo fatto di emozioni violente, ha modo di esprimere tutte le pulsioni della propria poetica insurrezionale rispetto all’accademia delle lettere e delle arti.
E questo, vale a dire il prevalere delle preoccupazioni letterarie su quelle sociali, ci permette di affrontare un problema solo apparentemente spinoso.
Il sole non è per noi è anche il romanzo che è costato a Léo Malet specifiche accuse di razzismo, e al quale si è ritornati, anche a più riprese, per spiegare l’involuzione politica dell’autore che, dopo un’adolescenza e una giovinezza vissuta sotto le bandiere dell’anarchismo, in vecchiaia si è trovato addirittura ad abbracciare le tesi xenofobe del Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen.
Detto che la bandiera di Léo Malet è soprattutto quella che lui stesso ricorda nella prefazione a La vita è uno schifo, ovvero «la bandiera color sangue e notte dell’inquietudine sessuale», va comunque concesso che alcune battute del romanzo possano apparire discutibili («Ma allora che cavolo vengono a cercare qui? Io, se fossi nato al sole…», si trova scritto a un certo punto a proposito degli algerini, e pare davvero di stare leggere certe dichiarazioni di esponenti politici contemporanei, o di catturare qualche frase scambiata oggi in un bar di periferia), ma è vero anche che nell’immediato dopoguerra, nei giorni seguenti quella che è stata la più grande carneficina della storia dell’umanità, avrebbe poco o nessun senso pretendere le precauzioni – che adesso si chiamano polically correct – che suggeriscono di non disegnare ruoli da “cattivo” a rappresentanti di popoli che siano stati nel passato o siano ancora nel presente vittime di persecuzioni razziali.
Proponendoci la figura dell’algerino cattivo (ma d’altronde anche il francesissimo Fredo lo è), Léo Malet dimostra di non avere sensi di colpa da espiare e nessuna forma di ipocrisia da contrabbandare: nel suo universo fortemente anti-rousseauiano non esistono i buoni e i cattivi, ma soltanto i predestinati. E i gesti si misurano non con il metro del valore etico ma con quello del tornaconto materiale. Trovare oggi negli arabi de Il sole non è per noi elementi tali da far sostenere un’accusa di razzismo, pare un’esercitazione vuota, scontata e un po’ volgare, come quella di chi si scaglia contro la raffigurazione “iconica” di neri o di cinesi nel cinema, nel fumetto e nella narrativa popolare. Il razzismo ha radici maggiormente insidiose, che mi pare poco abbiano a che spartire con il Léo Malet della Trilogia nera.
Predestinati, dicevo: la miseria sociale che emerge da Il sole non è per noi è più legata a caratteristiche peculiari della natura umana che a una visione politica della storia. Malet non crede alla lotta sociale capace di restituire un ruolo attivo, o anche solo la dignità umana, ai poveri cristi che popolano le sue pagine. Sono così è e così sempre saranno, sembra suggerire, accontentandosi di raccontare le loro storie, indagandone con diligenza ma anche con severità i luoghi e i modi della loro esistenza, senza la pietà che trasudava dalle pagine dei feuilleton di Eugène Sue e Paul Féval, in quelle di uno scrittore naturalista quale Emile Zola o, più avanti, di un reporter come Albert Londres. Per Malet, insomma, non esiste alcuna possibilità di redenzione, figuriamoci di giustizia: solo un grido poetico capace di smuovere emozioni nette, non contaminate da letture di parte, da gettare in faccia al conformismo e alla quiete borghese.
È già uno sguardo cinico, quello di Léo Malet («Solidarietà, strana parola», commenta a un certo punto il giovane André), lo sguardo di chi ha ben presente e ha sposato in toto la discussa affermazione seconda la quale “Chi non è stato anarchico da adolescente manca di cuore, chi lo è ancora a quarant’anni manca di cervello”. È lo sguardo di uno scrittore che attinge a piene mani nel proprio vissuto (i 16 anni a Parigi, il centro vegetariano, le notti trascorse sotto l’arco del ponte di Sully, i fraudolenti incidenti sul lavoro) quasi a dimostrare che l’unico modo di uscire dalle trappole del destino sono l’impeto rivoluzionario (ma un impeto come quello anarchico, vale a dire una posizione di rottura che non accetta compromessi) e quello poetico/letterario. Magari scrivendo romanzi di destinazione popolare che riescono ancora a smuovere emozioni a cinquant’anni e passa di distanza. Anzi, ritrovando proprio nella ciclicità dei periodi della storia, il presupposto di una straordinaria visione moderna.
Le disavventure di uno scrittore
Fra gli innumerevoli aneddoti che hanno costellato la vita di Lèo Malet, uno dei più strepitosi è stati il rifiuto a incontrare di nuovo André Breton dopo che questi era tornato in Francia, nel 1946, alla fine di un periodo trascorso all’esilio. Per Malet era una questione di rigore: o si è surrealisti o si scrivono romanzi polizieschi. E Malet, dall’ultima volta che aveva visto Breton, era diventato scrittore di romanzi polizieschi. Per questo aveva di colpo smesso di frequentare gli ambienti del surrealismo, mantenendo rapporti – epistolari – solo con René Magritte, che si sfiancava nel tentativo di convincerlo che la vena surrealista permeava anche i libri polizieschi che scriveva, anzi era proprio quella vena a renderli unici. Malet non si convinse mai del tutto. Scrivere gli piaceva, nel romanzo poliziesco aveva finalmente trovato la sua giusta espressione: tutto il resto poteva passare in secondo piano, appartenere al proprio passato.
Molti sono gli aneddoti, e altrettanti i crucci. Il maggiore, per Malet, fu senza dubbio quello di non approdare mai alla Sèrie Noire dell’editore Gallimard, la collana di maggior prestigio per chiunque si cimentasse nella scrittura di romanzo polizieschi. Ma forse, più che il cruccio in sé, a infastidire Males è stato l’aver dovuto rispondere centinaia di volte alla stessa domanda, l’aver dovuto ripetere a iosa la medesima spiegazione.
Malet e Marcel Duhamel, il creatore e per lungo tempo direttore della Série Noire, si conoscevano molto bene da prima della guerra. Erano entrambi amici di Jacques Prévert e frequentavano insieme il Cafè de Flore. Quando Malet si mise a scrivere, cominciò anche a mandare i testi in lettura a Duhamel, che invariabilmente gli rispondeva: «No, puoi fare di meglio». Quello che sulle prime sembrava un incoraggiamento, presto si rivelò soltanto un’espressione gentile di rifiuto. Una volta, un amico comune spedì a Duhamel alcuni romanzi di Malet già pubblicati, fra i quali La vita è uno schifo e Nebbia sul ponte di Tolbiac. La risposta del responsabile della Série Noire non tardò: «Ho sfogliato i romanzi di Malet che ha avuto la cortesia di inviarmi. Da quello che ho potuto vedere, si tratta di libri populisti che non corrispondono…» E qui Malet un po’ si innervosì. Intanto non gli era piaciuto per niente che Duhamel i libri li avesse solo “sfogliati” e non “letti”, non gli era piaciuto sia per il proprio, inevitabile, narcisismo di autore, sia per la stima che aveva sempre avuto per Duhamel. Non amava le persone che sfogliavano i libri, i libri si dovevano leggere, soprattutto quando si ricopriva il ruolo di direttore di collana. Poi c’era quell’aggettivo “populista”, che non gli andava proprio giù. Malet si interrogò, fece una specie di esame di coscienza, concluse che i suoi romanzi non erano più “populisti” di tanti altri. Duhamel però, nella stessa lettera, insisteva: «I romanzi polizieschi francesi sono sordidi, quelli americani sono di un livello più alto». Qui Malet non andò oltre un semplice: «Ah, sì? È un’opinione come un’altra». E i destini di Léo Malet e della Série Noire non si incrociarono mai.
Quando ebbe l’idea di scrivere La vita è uno schifo, Malet stava già pubblicando, con discreto successo, le prime avventure di Nestor Burma. La voglia di uscire dal campo specificatamente poliziesco per aggredire una tematica più noir gli era venuta a seguito del successo del romanzo Sputerò sulle vostre tombe, che Boris Vian aveva firmato con lo pseudonimo di Vernon Sullivan. Come ogni scrittore, anche Malet aveva un obiettivo di vendite: per lui le cinquantamila copie erano la cifra sulla quale misurare l’effettiva popolarità. Con La vita è uno schifo pensava di poter raggiungere per la prima volta il traguardo. Non ci arrivò, almeno non nell’immediato. La casa editrice fallì pochi giorni dopo la pubblicazione. Per fortuna di Malet, l’editore di Boris Vian riscattò l’intera tiratura e procedette a una nuova edizione, che si vendette abbastanza bene ma non superò – non subito – il tetto che l’autore si era imposto. A questo proposito, Malet non si perdonò mai di avere intitolato in quel modo il libro: «Nessuno in libreria osa chiedere un titolo del genere, si vergogna», si lamenterà poi.
Destino ancora più “nero” sarebbe toccato a Nodo alle budella. Scritto a ruota di La vita è uno schifo e Il sole non è per noi, è rimasto nel cassetto per ben ventidue anni (“Il y ètait tout seul, car, dans mes tiroirs rien ne traine!», scriverà Malet in un libro che può essere considerato una sorta di autobiografia, La vache enragée). Tratto dal racconto On ne tue pas le rêves, pubblicato su “Lectures de Paris”, Il sole non è per noi sarà edito soltanto nel 1969, grazie alla curiosità ricordata prima del regista Jean-Claude Rohmer.
Nodo alle budella è un romanzo meno costruito dei due precedenti, procede a scatti, alterna momenti di grande intensità ad altri in cui sembra che l’autore tiri il fiato per preparare la scena successiva. Paul Blondel, il protagonista, si muove anche lui disorganico, roso com’è dall’incubo che gli avvelena i sogni, quell’impiegatuccio grigio e occhialuto che per l’autore è la sintesi della faccia orribile e ripugnante di una società senz’anima. La resa dei conti con questo incubo, il trovarselo di fronte nella realtà, segnerà per Blondel l’impossibilità di tornare indietro, cercare passi diversi sui quali incamminare la propria vita. È un destino che lo lega a quello di Jean Fraiger e André Arnal, i protagonisti di La vita è uno schifo e Il sole non è per noi. Tutti e tre sono uomini per i quali il destino ha scelto la fine peggiore: cercano di opporsi al male della società commettendone a loro volta, ma è uno scalciare a vuoto, una ribellione che non produce risultati apprezzabili. Per Léo Malet, invece, che quello scalciare e quelle ribellioni, deposita nel cuore e nell’intelligenza dei propri lettori – alla fine enormemente di più dei cinquantamila che si era proposto di raggiungere – la Trilogia nera rappresenta il vertice della sua narrativa, un’opera che riscrive e codifica la grammatica del romanzo noir nella sua formulazione più genuina. Un’opera che, al pari di tutti i grandi classici, cresce d’importanza nel tempo e mantiene inalterata la propria leggibilità.
da Léo Malet, Trilogia nera, Fazi, 2003
mercoledì 30 giugno 2010
martedì 29 giugno 2010
Mano Nera - Il booktrailer.
Una Sarajevo livida, in attesa di una prima era che tarda a rivelarsi, assiste al rapi mento di Sanja e Nadira Karahasan, rispettivamente figlia e nipote di un ministro bosgnacco. Contemporaneamente, viene trafugato il tesoro più prezioso della Bosnia-Erzegovina, l'Haggadah di Sarajevo, un antico manoscritto sefardita custodito al Museo Nazionale e considerato il simbolo di una multi-culturalità che stenta ad affermarsi in una terra ancora ferita dalla guerra civile.
Mano Nera è il nuovo romanzo di Alberto Custerlina, disponibile in libreria dal 6 luglio 2010.
lunedì 28 giugno 2010
[Aggrappati alla crosta della terra.]
Abbiamo, mia cara, grandi similitudini che ci attaccano l’uno all’altra. Forse grandi nevrosi, grandi richieste da fare al mondo, a chi amiamo, a chi vogliamo bene. Abbiamo un’infinità di desideri, di voglie, di slanci, di entusiasmi. Abbiamo una sofferenza in comune che è quella per cui né tu né io amiamo la vita e la guardiamo come una cosa estranea ai nostri percorsi e che non ci interessa più di tanto; benchè questa stessa dolorosa sensibilità sia, paradossalmente, la radice di un nostro tutto particolare attaccamento al mondo.
Pier Vittorio Tondelli, Biglietti agli amici
Pier Vittorio Tondelli, Biglietti agli amici
domenica 27 giugno 2010
Quel fiore è lì, adesso. Quel fiore siete voi.
“scaveremo nei weekend, nelle sottoccupazioni, nei doppi lavori. Andremo presso i ladri di polli, i giovani artisti incantati, scenderemo sulle strade provinciali e comunali, incontreremo finalmente una marea di giovani improduttivi e selvatici, incazzati e morbidi, ubriaconi e struggenti”, ragazzi di cui i giornali non s’occuppano, che le trasmissioni non fanno parlare, le firme non intervistano.
Questi sono per me i giovani. Questi i ragazzi che danno speranza. Questi sono la novità: ragazzi che pensano e cercano nell’oscurità la propria via individuale, le proprie risorse, al di là del baccano, degli strombazzamenti, dei riflettori puntati, dei capelli e dei vestitini.
Ho appena terminato un romanzo di John Cheever, Il prigioniero di Falconer. Ho trovato un’immagine molto bella che cito a memoria: “Farragut sentì crescere nel deserto che era ormai il suo animo un fiore. Ma non lo trovò. Per questa sola ragione gli fu impossibile strapparlo.” L’esperienza giovanile degli anni settanta, suicidatasi per gran parte in fenomeni di illegalità e di tossicomania, ha fatto il deserto. Ma in quell’ansia distruttiva, suo malgrado, non è riuscita a strappare quel fiore.
Quel fiore è lì, adesso. Quel fiore siete voi.
— PierVittorio Tondelli, “Gli Scarti”
Da: “Un weekend postmoderno”
Questi sono per me i giovani. Questi i ragazzi che danno speranza. Questi sono la novità: ragazzi che pensano e cercano nell’oscurità la propria via individuale, le proprie risorse, al di là del baccano, degli strombazzamenti, dei riflettori puntati, dei capelli e dei vestitini.
Ho appena terminato un romanzo di John Cheever, Il prigioniero di Falconer. Ho trovato un’immagine molto bella che cito a memoria: “Farragut sentì crescere nel deserto che era ormai il suo animo un fiore. Ma non lo trovò. Per questa sola ragione gli fu impossibile strapparlo.” L’esperienza giovanile degli anni settanta, suicidatasi per gran parte in fenomeni di illegalità e di tossicomania, ha fatto il deserto. Ma in quell’ansia distruttiva, suo malgrado, non è riuscita a strappare quel fiore.
— PierVittorio Tondelli, “Gli Scarti”
Da: “Un weekend postmoderno”
Il tutto sta nell'avere una testa.
E con questo non sto dicendo che la televisione sia volgare e stupida perché le persone che compongono il Pubblico sono volgari e stupide. La televisione è ciò che è per il semplice motivo che la gente tende ad assomigliarsi terribilmente proprio nei suoi interessi volgari, morbosi e stupidi, e a essere estremamente diversa per quanto riguarda gli interessi raffinati, estetici e nobili.
— David Foster Wallace
da: Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più)
— David Foster Wallace
da: Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più)
[I libertini, li hanno disinnescati.]
E dice guarda, io mi sento che tutti mi leggono dentro come fossi di vetro che non ho più nemmeno un angolo in cui tenerci il cuore e il mio territorio di libertà, no, mi fanno male gli occhi della gente, è un momento così tante volte è passato ora sono qui tutto terremotato di dentro e sento questo sisma che mi traballa le budella e se sto seduto anche la sedia che l’altra sera al cinema ho gridato terremoto, terremoto e la gente ha urlato, però ero solo io e Paulette s’è messa a ridere, però non mi passa non mi passa santiddio, e piango una lacrima sull’altra che non so da dove vengano fuori, però escono e sembrano mare, salate e blu. E io gli dico te agli altri non devi manco pensare che sono tutti stronzi idioti e non sanno nemmeno cosa voglia dire essere liberi o felici, mentre tu lo sei perché hai la tua vita con gente bella che ti vuol bene e allora che ti frega, pensa a te che vali, pensa a noi che siamo la razza più bella che c’è, me lo ha insegnato Dilo questo, ridi, ridici pure su, noi sì che siamo una gran bella tribù. E allora mi sembra che piano piano tutto passi, ma si sa bene che non basta dire due parole o inventare uno scherzetto o fare una rima sciocca, e che quando uno ci ha i cazzi suoi, be’, sono veramente suoi, non c’è da fare un cazzo, manco gli stoici gli epicurei o i filosofi, niente. Non si può impedire a qualcuno di farsi o disfarsi la propria vita, si tenta, si soffre, si lotta ma le persone non sono di nessuno, nel bene o nel male.
Piervittorio Tondelli, Altri Libertini
Piervittorio Tondelli, Altri Libertini
[Come se tutto andasse per il meglio.]
La produzione culturale giovanile, per quanto - è chiaro - ci è dato vedere, sembra prediligere la leggerezza (che non è mai spaesamento) alla pensosità e alla riflessione (che non sono uggiosità). E’ come se il mondo dei sentimenti, delle passioni, della soffernza, dell’apprendistato faticoso, dello studio, della scoperta delle affinità elettive, della vocazione e del talento, fosse stemperato in un gran mare di faciloneria e di improvvisazione. Come se tutto andasse per il meglio. Come se ognuno di noi fosse contento di questa carnevalata malinconica e disperata che sono gli anni ottanta. Se l’euforia giovanile degli anni settanta ha prodotto la tragedia, la tragedia degli anni ottanta (non c’è niente di nuovo, niente per cui valga la pena di vivere) produce soltanto la farsa dei travestimenti e degli equivoci.
— PierVittorio Tondelli, “Scarti alla riscossa”
Da: “Un weekend postmoderno”
— PierVittorio Tondelli, “Scarti alla riscossa”
Da: “Un weekend postmoderno”
[Ritestualizzare il mondo.] P.V. Tondelli.
Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia qualcosa che io non so, che mi comunichi uno scarto nella mia visione delle cose e del mondo, che apra una braccia nella mia coscienza. Così imparo e mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi libri e nuovi romanzi. Ho profondamente bisogno di una continua “ritestualizzazione” del mondo. Perché il mondo così com’è non va bene. Occorre un cambiamento. E bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, non cambia il mondo, però cambia il suo modo di parlare. E forse anche il modo di sentirlo. Quando Peter Hadnke scrive “Io lavoro al mistero del mondo”, credo che produca un’emozionante indicazione poetica: bisogna lavorare, bisogna scrivere, bisogna pensare; ma non per un fine, quanto per essere inseriti in una collettività che abbraccia il primo e l’ultimo uomo che apparirà sulla terra.
— Piervittorio Tondelli, Post Pao Pao
da: “L’abbandono - racconti dagli anni ottanta”
— Piervittorio Tondelli, Post Pao Pao
da: “L’abbandono - racconti dagli anni ottanta”
Perchè D.F.W. era un genio.
Se la situazione della nostra civiltà contemporanea fa disperatamente schifo, è insulsa, materialistica, emotivamente ritardata, sadomasochistica e stupida, allora qualunque scrittore può sfangarla creando alla bell’e meglio storie piene di personaggi stupidi, superficiali, emotivamente ritardati, e non ci vuole molto, perché quel genere di personaggi non richiede nessuno sviluppo. O descrizioni che siano semplici liste di prodotti di marca. Romanzi in cui gente stupida si dice cose insignificanti. Se quello che ha sempre contraddistinto la cattiva scrittura – la piattezza dei personaggi; un mondo narrativo fatto di cliché e non riconoscibile come umano – è anche ciò che contraddistingue il mondo di oggi, allora un brutto romanzo diventa una geniale mimesi di un brutto mondo. Se i lettori credono semplicemente che il mondo sia stupido, superficiale e cattivo, allora uno come Bret Easton Ellis può scrivere un romanzo cattivo, stupido e superficiale che diventa un ironico e tagliente ritratto della bruttura del mondo che ci circonda. Siamo d’accordo un po’ tutti che questi sono tempi bui, e stupidi, ma abbiamo davvero bisogno di opere letterarie che non facciano altro che mettere in scena il fatto che sia tutto buio e stupido? Nei tempi bui, quello che definisce una buona opera d’arte mi sembra che sia la capacità di individuare e fare la respirazione bocca a bocca a quegli elementi di umanità e di magia che ancora sopravvivono ed emettono luce nonostante l’oscurità dei tempi. La buona letteratura può avere una visione del mondo cupa quanto vogliamo, ma troverà sempre un modo sia per raffigurare il mondo sia per mettere in luce le possibilità di abitarlo in maniera viva e umana.
Non parlo di soluzioni nel campo della politica convenzionale o dell’attivismo sociale. Il campo della letteratura non si occupa di questo. La letteratura si occupa di cosa cazzo voglia dire sentirsi un essere umano. Se uno parte, come partiamo quasi tutti, dalla premessa che negli Stati Uniti di oggi ci sono cose che ci rendono decisamente difficile essere veri esseri umani, allora forse metà del compito della letteratura è spiegare da dove nasce questa difficoltà. Ma l’altra metà è mettere in scena il fatto che nonostante tutto siamo ancora esseri umani. O possiamo esserlo. Questo non significa che il compito della letteratura sia edificare o insegnare, fare di noi tanti piccoli bravi cristiani o repubblicani. Non sto cercando di seguire le orme di Tolstoj o di John Gardner. Penso solo che la letteratura che non esplora quello che significa essere umani oggi non sia arte. Abbiamo tanta narrativa “di qualità” che ripete semplicemente all’infinito il fatto che stiamo perdendo sempre più la nostra umanità, che presenta personaggi senz’anima e senza amore, personaggi la cui descrizione si può esaurire nell’elenco delle marche di abbigliamento che indossano, e noi leggiamo questi libri e diciamo: “Wow, che ritratto tagliente ed efficace del materialismo contemporaneo!”. Ma che la cultura americana sia materialistica lo sappiamo già. E’ una diagnosi che si può fare in due righe. Non è stimolante. Ciò che è stimolante e ha una vera consistenza artistica è, dando per assodata l’idea che il presente sia grottescamente materialistico, cercare di capire questo: come mai noi esseri umani abbiamo ancora la capacità di provare gioia, carità, sentimenti di autentico legame, per cose che non hanno un prezzo? E queste capacità si possono far crescere? Se sì, come, e se no, perché?
— David Foster Wallace – Brevi interviste con David Foster Wallace (da La ragazza dai capelli strani)
Non parlo di soluzioni nel campo della politica convenzionale o dell’attivismo sociale. Il campo della letteratura non si occupa di questo. La letteratura si occupa di cosa cazzo voglia dire sentirsi un essere umano. Se uno parte, come partiamo quasi tutti, dalla premessa che negli Stati Uniti di oggi ci sono cose che ci rendono decisamente difficile essere veri esseri umani, allora forse metà del compito della letteratura è spiegare da dove nasce questa difficoltà. Ma l’altra metà è mettere in scena il fatto che nonostante tutto siamo ancora esseri umani. O possiamo esserlo. Questo non significa che il compito della letteratura sia edificare o insegnare, fare di noi tanti piccoli bravi cristiani o repubblicani. Non sto cercando di seguire le orme di Tolstoj o di John Gardner. Penso solo che la letteratura che non esplora quello che significa essere umani oggi non sia arte. Abbiamo tanta narrativa “di qualità” che ripete semplicemente all’infinito il fatto che stiamo perdendo sempre più la nostra umanità, che presenta personaggi senz’anima e senza amore, personaggi la cui descrizione si può esaurire nell’elenco delle marche di abbigliamento che indossano, e noi leggiamo questi libri e diciamo: “Wow, che ritratto tagliente ed efficace del materialismo contemporaneo!”. Ma che la cultura americana sia materialistica lo sappiamo già. E’ una diagnosi che si può fare in due righe. Non è stimolante. Ciò che è stimolante e ha una vera consistenza artistica è, dando per assodata l’idea che il presente sia grottescamente materialistico, cercare di capire questo: come mai noi esseri umani abbiamo ancora la capacità di provare gioia, carità, sentimenti di autentico legame, per cose che non hanno un prezzo? E queste capacità si possono far crescere? Se sì, come, e se no, perché?
— David Foster Wallace – Brevi interviste con David Foster Wallace (da La ragazza dai capelli strani)
[Il complotto per la felicità.]
Ho delle cicatrici sulle mani causate dal contatto con un certo tipo di persone. Una volta, nel parco, quando Fanny era ancora in carrozzina, le misi una mano sulla parte tenera del capo e ve la lasciai troppo a lungo. Un’altra volta, mi capitò con Zooey durante un film dell’orrore al cinema Loew sulla Settantaduesima strada. Non aveva più di sei o sette anni e si nascose dietro il sedile per non guardare la scena che lo impauriva. Gli misi una mano sul capo. Certe teste, il colore e la consistenza di certe capigliature mi lasciano segni indelebili. E c’è altro. Una volta Charlotte si mise a correre lontano da me, fuori dello studio ed io le afferrai il vestito giallo, di cotone, che mi piaceva moltissimo perché le stava troppo lungo. Ho ancora il segno giallo limone sul palmo della mano destra. Oh, mio Dio, se la mia personalità può essere definita clinicamente, allora sono una specie di paranoico alla rovescia. Ho il sospetto che tutti stiano complottando per farmi felice.
Da “Alzate l’architrave carpentieri e Seymour” di J.D. Salinger
Da “Alzate l’architrave carpentieri e Seymour” di J.D. Salinger
(Being hatepeople).
Me ne andai in giro estendendo il mio odio a tutto ciò che era opera dell’uomo, alle linee tranviarie, alla numerazione delle case, ai titoli, alla distribuzione del tempo, a tutto quel guazzabuglio trito e macchinoso che si chiama ordine, me la presi con il servizio della nettezza urbana, col calendario delle lezioni, con l’ufficio di stato civile, con tutte quelle miserabili istituzioni contro le quali è impossibile scagliarsi, contro le quali infatti nessuno si scaglia, quegli altari sui quali anch’io mi ero sacrificato, ma non ero disposto a permettere che mio figlio si sacrificasse. Come c’era arrivato mio figlio? Non era stato lui a organizzare il mondo, a causarne i guasti. Perché dunque avrebbe dovuto adattarsi a viverci? Imprecai contro l’anagrafe, le scuole, le caserme: Dategli un’opportunità! Date a mio figlio, prima che si rovini, almeno un’opportunità! Imprecavo contro me stesso perché avevo costretto mio figlio a venire in questo mondo senza far nulla per liberarlo. Questo glielo dovevo, dovevo agire, partire con lui, andare su un’isola deserta. Ma dove esiste quest’isola dove un uomo nuovo può fondare un mondo nuovo? Io ero prigioniero insieme al bambino, e condannato sin dall’inizio a far parte del vecchio mondo. Perciò abbandonai il bambino. Gli tolsi il mio amore. Questo bambino era capace di tutto, era solo incapace di una cosa, di uscir fuori, di rompere quel cerchio infernale.
Il trentesimo anno - I. Bachmann
Il trentesimo anno - I. Bachmann
sabato 26 giugno 2010
(Missing part.)
Sì, c'è qualcosa che non ti ho mai raccontato, a dire il vero.
Forse ti sarebbe piaciuta questa storia. E' una delle nostre, sai, quelle da quindicenni in crisi di identità che non si risolvono mai, neanche a quarant'anni, per chi ci vuole arrivare a quarant'anni.
Già ti vedo dietro questa pagina bianca che mi fa prendere paura.
Mi avresti scritto che t'avevo fatto piangere, anche se non era vero. O forse sì.
Mi avresti allegato le tue lacrime in copia carbone, un paio di abbracci virtuali, una carezza inconsistente tra i capelli. E poi avresti premuto invio, senza pensarci troppo su. O forse sì.
Io avrei aspettato la tua risposta mentre mi masticavo un sorriso storto tra i denti.
E avrei fatto finta di leggere sotto tutto questo bianco qualcosa che non avresti mai voluto dirmi. O forse sì.
Avrei cercato rifugio nei tuoi spazi personali, perchè i miei avevano già cominciato ad annoiarmi e a starmi troppo stretti.
Non riusciamo mai a fermarci, mi scrivevi.
Senza la nostra irrequietezza smettiamo di esistere, ti scrivevo.
venerdì 25 giugno 2010
giovedì 24 giugno 2010
Review su "Salto d'ottava", A. Paolacci.
Ora, non avrò la giusta obiettività o competenza per scriverlo, ma non credo che di teste come quella di Antonio Paolacci se ne trovino molte in giro. Non è solo una prova di talento o di stile, questa sua seconda fatica. E' una grande prova di intelligenza. Paolacci sa scrivere e soprattutto pensa prima di farlo, cosa che vi sembrerà banale, ma visti i tempi che corrono non lo è affatto. In più pensa con coraggio, tira fuori una salda coscienza critica antigenerazionale, una vitale e brutale onestà intellettuale, tenendosi lontano dall’etichetta di genere come già aveva dimostrato di saper fare nel suo romanzo d’esordio, “Flemma” (Perdisa Pop, 2007).E soprattutto riesce a dire quello che deve e che vuole dire nei suoi romanzi, senza il bisogno di dirlo al di fuori.
Se non è roba rara, questa. Fate voi.
Se non è roba rara, questa. Fate voi.
lunedì 14 giugno 2010
[Sotto la doccia.]
Essere scrittori significa riuscire a dire nei propri libri quello che si pensa sul mondo e sulla gente,senza il bisogno di dirlo al di fuori.
Magari di tanto in tanto a dirlo anche come si deve.
domenica 13 giugno 2010
[Lullaby, B. Baraldi.] Review a cura di Giulia Guida.
Giada e Marcello sembrano disegnati in una di quelle vecchie fiabe in cui il lieto fine può essere solo un colpo di scena, ma non arriva mai davvero, non arriva mai alla fine. Uno di quei racconti in cui anche il male esiste e spesso finisce per avere la meglio. Qualsiasi lotta è vana, l'eroe deve morire o sentire la morte. Vederla accadere. Tutte le sue peripezie, altrimenti, non avrebbero alcun senso. Resta lui solo aggrappato ai bordi dell'ultima pagina. Vivo, certo, ma irriversibilmente solo. Il sangue e la morte sono gli oggetti magici necessari a ristabilire l'ordine iniziale, tornare a riappropriarsi della vita, ridare un valore alle parole, ripulire gli anni dai silenzi meteoritici e dai detriti di bugie ammucchiati in ogni stanza.
Lullaby.
Lullaby.
Quando scrivere diventa un dare nomi.
Non è un discorso semplice.
Non nella pratica, perlomeno.
Parlare di etichette, letteratura di genere, schemi fissi, cliches feticcio.
Ci si chiede in che modo lo scrittore/scrivente abbia il dovere di approcciarsi alla pagina bianca, quali direttive debba prendere, quali direzioni seguire, in che contesto inquadrare quello che produce.
La realtà dei fatti è che le etichette e le divisioni per genere, utili a far ordine negli scaffali delle librerie, non corrispondono spesso a parametri obiettivi e vengono decise a tavolino, in base a criteri del tutto arbitrari.
Ridurre l'intero impianto strutturale di un romanzo, i meccanismi di base del suo intreccio, le dinamiche di varia natura che regolano i rapporti tra i personaggi alla definizione di un solo genere penalizza di molto il lavoro in sè, porta in evidenza unicamente quei tratti serializzati che si presentano sempre uguali, in situazioni spesso analoghe, in tutti i romanzi riconducibili a quel determinato genere. Attribuire etichette implica marchiare a fuoco, dare un ruolo, un nome, una funzione, creare delle aspettative in base a tutto quel che già si sa relativamente a un dato genere e che da quel genere ci si aspetta. Non si tratta di eliminare l'etichetta, è chiaro.
C'è bisogno di definire, inquadrare, contestualizzare per non perdere le coordinate.
Ma dovrebbe essere un dovere per scrittori, editori, lettori e critici istituzionali o meno, cercare di rifuggire il più possibile da parametri già fissati nella valutazione di un lavoro nuovo. Dovrebbe essere un dovere sentito andare a scomporre i vari aspetti su cui si fonda l'opera, non tirare fuori quello più evidente o più facilmente inquadrabile, facendolo passare per l'unico aspetto riscontrabile.
Scrivere di un omicidio non fa di te uno scrittore di gialli.
Scrivere di sesso non ti rende un autore di letteratura erotica.
Scrivere di torture e perversioni non ti dona all'istante il fascino del gotico.
Scrivere d'amore non ti fa piombare fortunatamente nell'universo rosa dei romanzi harmony.
Una grande responsabilità se la devono assumere gli scrittori, in questo senso.
Cercare di sperimentare quanto più possibile in modo tale da dare vita a qualcosa che non possa trovare una sola definizione. Che abbia fonti e generi di ispirazione, beninteso, ma che li sintetizzi e li riutilizzi in maniera originale, rendendoli parte del substrato più profondo. Recuperare i modelli e inserirli nel tessuto, così da disorientare, creare scompiglio, perplessità.
Il lettore, una volta arrivato all'ultima pagina, deve chiudere il libro e domandarsi che diamine di libro abbia appena letto. Non deve poter avere la certezza di dire soltanto: "Ho letto un noir/un romanzo d'amore/un'autobiografia/un pezzo di satira". Deve poter dire che ha letto tutto questo mescolato assieme.
Ci sono autori di nuova generazione che stanno spingendo molto in questa direzione e hanno già ottenuto ottimi risultati. Partire da un pretesto (ex: un omicidio, una sparizione, un sequestro, se si parla di lavori riconducibili parzialmente al noir e annessi) che finisce poi per diventare elemento di fondo, accessorio secondario della narrazione, anello di congiunzione tra le diverse storie, punto di contatto tra i vari personaggi.
Un pretesto che occupi più o meno spazio nella narrazione, necessario a far emergere qualcosa di diverso: un messaggio che faccia da filo di collegamento ideologico tra i vari passaggi, farlo trasparire attraverso gli eventi, le azioni ed i pensieri, mentre l'evento centrale che dà avvio al romanzo può giungere parallelamente alla sua risoluzione o meno.
In sintesi, le storie non andrebbero chiuse in compartimenti stagni come accade di frequente, non dovrebbero essere ritagliate per rispettare certi canoni da copione, impianti narrativi standard e tratti distintivi di genere.
E' necessario spaziare in ambiti diversi, sconfinare dal proprio territorio e invaderne altri con prepotenza.
Piantare la bandiera in ogni terra e così facendo in nessuna.
E' impossibile descrivere il mondo in un romanzo, se ne può parlare da alcune angolazioni, si possono scegliere prospettive piuttosto che altre, si possono trattare temi specifici, ma non chiudiamo troppo i confini a questo mondo da raccontare. Se ne vede troppo spesso la stessa piccola porzione.
Rinunciare alle etichette comporta per forza di cose una serie di rischi.
Primo fra tutti l'incomprensione che deriva dal mancato inquadramento.
Tutto quello che non può trovare definizione necessariamente sfugge, è inafferrabile.
Ma la bellezza esercitata da tutto ciò che è più incomprensibile non ha niente a che vedere con il potere rassicurante dato da una definizione.
Perciò mischiate i generi il più possibile, lasciate scorrere le vostre storie così come nascono senza porre troppi impedimenti teorici lungo il percorso. E' un grande passo per sfuggire all'omologazione.
E gli editori, da parte opposta, dovrebbero imparare a superare essi stessi i limiti di genere e aprirsi alla pubblicazione o anche alla semplice lettura e promozione di lavori nuovi, sperimentali, che trovino il loro punto di forza proprio in questo.
Nell'impossibilità della definizione.
Non nella pratica, perlomeno.
Parlare di etichette, letteratura di genere, schemi fissi, cliches feticcio.
Ci si chiede in che modo lo scrittore/scrivente abbia il dovere di approcciarsi alla pagina bianca, quali direttive debba prendere, quali direzioni seguire, in che contesto inquadrare quello che produce.
La realtà dei fatti è che le etichette e le divisioni per genere, utili a far ordine negli scaffali delle librerie, non corrispondono spesso a parametri obiettivi e vengono decise a tavolino, in base a criteri del tutto arbitrari.
Ridurre l'intero impianto strutturale di un romanzo, i meccanismi di base del suo intreccio, le dinamiche di varia natura che regolano i rapporti tra i personaggi alla definizione di un solo genere penalizza di molto il lavoro in sè, porta in evidenza unicamente quei tratti serializzati che si presentano sempre uguali, in situazioni spesso analoghe, in tutti i romanzi riconducibili a quel determinato genere. Attribuire etichette implica marchiare a fuoco, dare un ruolo, un nome, una funzione, creare delle aspettative in base a tutto quel che già si sa relativamente a un dato genere e che da quel genere ci si aspetta. Non si tratta di eliminare l'etichetta, è chiaro.
C'è bisogno di definire, inquadrare, contestualizzare per non perdere le coordinate.
Ma dovrebbe essere un dovere per scrittori, editori, lettori e critici istituzionali o meno, cercare di rifuggire il più possibile da parametri già fissati nella valutazione di un lavoro nuovo. Dovrebbe essere un dovere sentito andare a scomporre i vari aspetti su cui si fonda l'opera, non tirare fuori quello più evidente o più facilmente inquadrabile, facendolo passare per l'unico aspetto riscontrabile.
Scrivere di un omicidio non fa di te uno scrittore di gialli.
Scrivere di sesso non ti rende un autore di letteratura erotica.
Scrivere di torture e perversioni non ti dona all'istante il fascino del gotico.
Scrivere d'amore non ti fa piombare fortunatamente nell'universo rosa dei romanzi harmony.
Una grande responsabilità se la devono assumere gli scrittori, in questo senso.
Cercare di sperimentare quanto più possibile in modo tale da dare vita a qualcosa che non possa trovare una sola definizione. Che abbia fonti e generi di ispirazione, beninteso, ma che li sintetizzi e li riutilizzi in maniera originale, rendendoli parte del substrato più profondo. Recuperare i modelli e inserirli nel tessuto, così da disorientare, creare scompiglio, perplessità.
Il lettore, una volta arrivato all'ultima pagina, deve chiudere il libro e domandarsi che diamine di libro abbia appena letto. Non deve poter avere la certezza di dire soltanto: "Ho letto un noir/un romanzo d'amore/un'autobiografia/un pezzo di satira". Deve poter dire che ha letto tutto questo mescolato assieme.
Ci sono autori di nuova generazione che stanno spingendo molto in questa direzione e hanno già ottenuto ottimi risultati. Partire da un pretesto (ex: un omicidio, una sparizione, un sequestro, se si parla di lavori riconducibili parzialmente al noir e annessi) che finisce poi per diventare elemento di fondo, accessorio secondario della narrazione, anello di congiunzione tra le diverse storie, punto di contatto tra i vari personaggi.
Un pretesto che occupi più o meno spazio nella narrazione, necessario a far emergere qualcosa di diverso: un messaggio che faccia da filo di collegamento ideologico tra i vari passaggi, farlo trasparire attraverso gli eventi, le azioni ed i pensieri, mentre l'evento centrale che dà avvio al romanzo può giungere parallelamente alla sua risoluzione o meno.
In sintesi, le storie non andrebbero chiuse in compartimenti stagni come accade di frequente, non dovrebbero essere ritagliate per rispettare certi canoni da copione, impianti narrativi standard e tratti distintivi di genere.
E' necessario spaziare in ambiti diversi, sconfinare dal proprio territorio e invaderne altri con prepotenza.
Piantare la bandiera in ogni terra e così facendo in nessuna.
E' impossibile descrivere il mondo in un romanzo, se ne può parlare da alcune angolazioni, si possono scegliere prospettive piuttosto che altre, si possono trattare temi specifici, ma non chiudiamo troppo i confini a questo mondo da raccontare. Se ne vede troppo spesso la stessa piccola porzione.
Rinunciare alle etichette comporta per forza di cose una serie di rischi.
Primo fra tutti l'incomprensione che deriva dal mancato inquadramento.
Tutto quello che non può trovare definizione necessariamente sfugge, è inafferrabile.
Ma la bellezza esercitata da tutto ciò che è più incomprensibile non ha niente a che vedere con il potere rassicurante dato da una definizione.
Perciò mischiate i generi il più possibile, lasciate scorrere le vostre storie così come nascono senza porre troppi impedimenti teorici lungo il percorso. E' un grande passo per sfuggire all'omologazione.
E gli editori, da parte opposta, dovrebbero imparare a superare essi stessi i limiti di genere e aprirsi alla pubblicazione o anche alla semplice lettura e promozione di lavori nuovi, sperimentali, che trovino il loro punto di forza proprio in questo.
Nell'impossibilità della definizione.
martedì 8 giugno 2010
"Istruzioni per un addio". Review a cura di Giulia Guida.
Carrino annulla il tempo, ne annulla l'ordine logico. Riesce a ricreare la geometria molecolare di un sentimento, l'addio, che è in realtà dato di fatto, uno stato irreversibile di cose, una realtà ruvida, sporca, l'inizio di una crisi, una crepa nella quotidianità, nei luoghi di sempre, nelle vecchie abitudini. L'addio è la vita che smette di scorrere all'improvviso. E' la frattura che non si ricompone o lo fa storta attraverso gli anni e s'attacca all'odore dei vestiti di chi se ne è andato, a un sorriso lasciato di sfuggita dentro una foto, nella pancia cava delle pareti delle case disabitate, tra le pieghe della carne di un corpo solo che si invecchia. L'addio è figura geometrica dagli angoli infiniti, è cerchio in cui ci si smarrisce, è linea retta che trema di infinito e di morte.
Istruzioni per un addio.
Istruzioni per un addio.
domenica 6 giugno 2010
Niente sconti.
"Vedete, se c'è una cosa sbagliata in tutto questo, è il lieto fine. I vostri personaggi corrono attraverso la vita come verso un precipizio e fate di tutto per salvarli. Salvare loro sulla carta almeno, dato che non potete salvare voi stessi nella realtà. Basterebbe così poco invece. Basterebbe lasciarli cadere nel precipizio, senza troppo rimorso. Così come ci cadete voi."
venerdì 4 giugno 2010
La conta, L. Bernardi. Review a cura di Giulia Guida.
L'uomo vuole sapere, soffre di una curiosità sfrenata che sconfina nell'ossessione, nella morbosità della patologia, nell'allucinazione visiva. Vuole conoscere a memoria le vittime e i loro assassini, marchiare la sua pelle con le loro impronte digitali, codici da decriptare nel tempo fino alla soluzione finale, allo scioglimento dell'enigma, al crittogramma di svolta, quello che permetterà di tradurre la morte violenta anche ai vivi, di darle un movente, di catalogarla finalmente, trovarle un posto in una scatola impolverata per poi chiudere il caso. E ricominciare a contare.
La conta, L. Bernardi.
giovedì 3 giugno 2010
Rubrica prossime uscite: "Salto d'ottava", A. Paolacci.
Un uomo e un ragazzo. Ventiquattro ore per entrambi. Il cadavere di un adolescente riverso sul pavimento di una fabbrica abbandonata, in una città che la ignora pur considerandola uno dei tanti problemi da risolvere. L'uomo è un produttore cinematografico di una piccola casa indipendente, preda di una bizzarra forma di smarrimento. È un individuo che ha atteso e che attenderà fino all'ultimo momento. Il ragazzo, un sedicenne affascinato dalla cultura dello skateboard, per puro caso s'imbatte nel cadavere di un suo coetaneo. È l'inizio delle domande. Omicidio? Incidente? Ma importa davvero scoprirlo? Sullo sfondo, una sessualità vissuta di nascosto: incontri anonimi, trasgressioni e prostituzione s'incrociano a un'eloquente poetica delle persone qualunque.
Potente, puntellata su un realismo che lascia spazio a elementi di visionarietà, Salto d'ottava, oltre a essere una storia che si divora tutta d'un fiato anche grazie all'alternanza delle situazioni, è un apologo duro sull'indifferenza, l'apatia e il disorientamento di giovani e adulti, in un mondo che sembra premiare l'egocentrismo del singolo, ma contemporaneamente lo castiga attraverso il timore delle possibili reazioni all'eccesso di individualismo.
Fra pubblico e privato, sofferenza e narcisismo, suspense e affresco del sottobosco urbano, il secondo libro di Antonio Paolacci è una novella esemplare, illuminata da una scrittura attenta e consapevole: la conferma di un talento della nuova narrativa italiana.
Antonio Paolacci è nato nel 1974. È originario del Cilento ma vive a Bologna. Laureato in Discipline dello Spettacolo, si è occupato di psicanalisi e cinema, scrivendo articoli e tenendo lezioni all'università. Attualmente è editor e consulente editoriale. Dal 2008 coordina le giurie del premio letterario Lama e trama. Ha pubblicato racconti su rivista e antologia. Nel 2007 ha esordito con il romanzo Flemma (Perdisa Pop).
Fra qualche giorno dovrebbe arrivare a casa. Stay tuned sulle reviews.
Potente, puntellata su un realismo che lascia spazio a elementi di visionarietà, Salto d'ottava, oltre a essere una storia che si divora tutta d'un fiato anche grazie all'alternanza delle situazioni, è un apologo duro sull'indifferenza, l'apatia e il disorientamento di giovani e adulti, in un mondo che sembra premiare l'egocentrismo del singolo, ma contemporaneamente lo castiga attraverso il timore delle possibili reazioni all'eccesso di individualismo.
Fra pubblico e privato, sofferenza e narcisismo, suspense e affresco del sottobosco urbano, il secondo libro di Antonio Paolacci è una novella esemplare, illuminata da una scrittura attenta e consapevole: la conferma di un talento della nuova narrativa italiana.
Antonio Paolacci è nato nel 1974. È originario del Cilento ma vive a Bologna. Laureato in Discipline dello Spettacolo, si è occupato di psicanalisi e cinema, scrivendo articoli e tenendo lezioni all'università. Attualmente è editor e consulente editoriale. Dal 2008 coordina le giurie del premio letterario Lama e trama. Ha pubblicato racconti su rivista e antologia. Nel 2007 ha esordito con il romanzo Flemma (Perdisa Pop).
Fra qualche giorno dovrebbe arrivare a casa. Stay tuned sulle reviews.
mercoledì 2 giugno 2010
Perché l'inedito di Nick Corey non deve rimanere inedito.
Quando Zannoni mi ha inviato una copia del suo nuovo lavoro, ancora inedito, "Le cose di cui sono capace", mi ha scritto una breve ma esaustiva premessa, che suonava all'incirca così: " E' la prima volta che mi invento tutto di sana pianta. Finalmente ce l'ho fatta, cazzo."
Il che credo meriti qualche minuto di riflessione.
Giocare con la vita reale e ricamarci su può essere uno dei modi di raccontare una storia. Cosa che richiede ad ogni modo un certo stile. Non basta aver vissuto a perdifiato e controvento per poterci scrivere un romanzo, serve anche una stoffa per parare i colpi che l'esperienza non ti può regalare.
Un altro modo per raccontare una storia è inventarla. Tutta di sana pianta.
Una storia che non abbia alcun punto di contatto con la realtà che si conosce la si deve immaginare.
Creare dei personaggi, ambientazioni nuove, una sceneggiatura che non è ancora stata vissuta, perciò è tutta da scrivere. E' un salto nel vuoto, da una parte. Una sfida alle tue capacità, per tastare con mano i limiti del tuo talento, per sentire se in qualche punto della strada la tua storia puzza troppo della vita che ti si è ammucchiata addosso o zoppica un pò tra quelle righe tutte bianche che non sai proprio come riempire, tanto che alla fine ci attacchi su gli stessi scatti che sono appesi alle pareti della tua stanza.
Quello che sorride lì sul foglio sei tu e non ti nascondi neanche tanto bene.
Ecco, invece Zannoni questa volta ce l'ha fatta. A inventarsi tutto di sana pianta, ma ce l'ha fatta mettendoci del suo, chiaro. E se c'è una cosa che non posso non apprezzare in uno scrittore oggi è la capacità di essere originale nei piccoli dettagli, trovare il punto di fuga giusto che gli permetta di battere la ritirata dalle etichette più comuni, dalle definizioni di genere, dai parametri standard della critica.
"Le cose di cui sono capace" è un tipico racconto americano, molto alcolico, di quelli con tanto sesso e troppe parolacce.
L'idea originaria di Zannoni era di buttar giù un omaggio a "Colpo di spugna" di Jim Thompson, un americano troppo nero per essere solo noir. Il protagonista del romanzo - o per meglio dire dei due romanzi paralleli - è Nick Corey, lo pseudonimo con cui Zannoni si presenta in giro per il web da qualche mese a questa parte. Perché è sempre il solito megalomane e un'identità sola non gli basta.
Thompson gli avrebbe detto che per essere un cazzo di omaggio era scritto troppo bene, però che la smettesse di usare il nome del suo amico che tanto - cosa credeva - avrebbe comunque fatto la fame, gli avrebbe ridato indietro il libraccio senza salamelecchi e poi ci si sarebbe ubriacato insieme, che è comunque un gran modo di dire grazie.
Perchè alla sua maniera Zannoni dimostra che le cose di cui è stato capace questa volta non sono roba da tutti.
Il primo colpo di genio del nostro uomo dall'identità variabile sta proprio in questo: nell'essere riuscito a intrecciare i vari passaggi in modo tale da mostrare al lettore come lo sceriffo Nick Corey non sia altro che il risultato di un processo di americanizzazione di Nicola Coretti, cambiando quindi il background di base del personaggio e trasferendolo in un contesto diverso dall'originale.
Il secondo colpo di testa è di aver ripreso la struttura del romanzo americano sullo stile di Lansdale e Leonard, spesso troppo standardizzato e seriale, e di averlo sabotato dall'interno.
E' una critica sottile, quella di Zannoni.
Una buona lezione contro il rischio della ripetitività e della monotonia che spesso fanno di uno scrittore un autore di bestsellers a tiratura illimitata.
Non ha scelto di criticare da fuori.
Ha preso il noir americano e l'ha scrollato dalle fondamenta. L'ha smontato pezzo per pezzo. Battuta dopo battuta. Scena dopo scena. Senza esporsi mai più del dovuto, giocando d'azzardo in sottobanco. Tutto è così esasperatamente americano che non ti verrebbe mai in mente, abituato come sei a veder circolare certo materiale in giro, che questo piccolo gioiello intriso di Texas, deserto e di puttane sia una squisita presa per il culo del genere stesso a cui appartiene.
Zannoni ha preso i suoi personaggi, tutti nati e vissuti da bravi americani. Abituati a pensare che niente sia impossibile solo perchè sono cresciuti America, la terra del grande sogno e dell'enorme incubo. Ha pensato di disegnare bene questi figli di puttana ad uno ad uno, di farli ritrovare di punto in bianco in mezzo a un inseguimento all’ultimo secondo o a una sparatoria mortale e magari è riuscito anche a farli uscire vivi e senza troppi graffi. Imperfetti sì, quello è imprescindibile. Altrimenti non sarebbero vivi.
C'è questa scena, per dirne un’altra, in cui Corey e il suo amico Rudy stanno pisciando tra le rose di Reyna, la moglie di Rudy, una iena rapace, sempre lì a sputare e ingoiare veleno, a prendere a morsi anche l'aria- allora c'è questa scena in cui i due malcapitati vedono arrivare una macchina al rallentatore verso di loro. E da qui il riferimento parte automatico. I due sbandati dei fratelli dei Coen e Bridges, nella regolare tenuta accappatoio e mutande intento a giocare a bowling tra un white russian e un altro, si mettono di traverso tra le battute per rendere la scena esilarantemente americana, mentre Jeff continua a darsi a fuoco all'accappatoio con la sigaretta accesa.
Il terzo motivo per cui un romanzo così dovrebbe stare sotto il vostro culo adesso è che tutto quello che è venuto fuori da questo sabotaggio clandestino è l'amore.
Perciò Zannoni non si limita a riutilizzare il modello americano, esasperando i suoi cliches, tratti distintivi e le sue tematiche feticcio, ma ci lascia anche la firma. Una qualche puttanata la doveva sparare e la spara lì, come da copione. Quello che viene fuori da qui, invece, è un uomo vero, in carne ed ossa, irrimediabilmente innamorato. Non un eroe da missione apocalittica. Uno che corre sul filo del rasoio, sì, che sfiora la morte allo scoccare del secondo, ma sempre per una donna o per quel buon diavolo di Rudy, che qualcuno lo dovrà pur aiutare.
E uno sceriffo, diamine, dovrà pur darsi un tono. Prima o poi.
[Nelle nostre stanze.]
Giravamo tra i tendoni della fiera da ore, il mio gomito contro il tuo senza toccarci mai.
Il tuo sguardo giallo di delusione mi bruciava addosso. Avevi messo su quel rossetto opaco, rosso di tutte le lacrime che ti nascondevi nelle guance. Mi volevi lontana da te. E io non sapevo come avvicinarmi. Vedevo la mia bocca contro il tuo orecchio per dirti che mi dispiaceva. Ma non succedeva mai. Non riuscivo più a fermarmi nei tuoi occhi scuri tutti accartocciati. Volevo morderli come granelli di nocciola e ingoiarti giù con me, portarti nel sangue e non doverti più abbandonare. Morire così, da ragazzine come eravamo cresciute insieme.
Ma tu già mi camminavi davanti, da sola. Era pieno di gente intorno, tutti mascherati, anche tu. Tutti mascherati tranne me, che mi sentivo nuda e volevo solo chiederti scusa, ma sapevo già che non avrei detto niente e me ne sarei andata. Avrei chiuso la porta di tutte le tue stanze alle mie spalle e ti avrei lasciato la chiave.
E poi ho sentito la tua voce da lontano arrivarmi contro il petto. - Credo che questa ti starebbe bene, no? Era il ciondolo che cercavi.- Le tue mani da bambina mi hanno messo al collo questa chiave e volevo dirti non immagini quanto pesa, perchè sei sempre stata tu quella con le chiavi giuste, io ero solo quella con la valigia in mano e le chiavi me le perdevo ogni sera, ti ricordi, a casa non ci volevo mai tornare, ma questa, sai, questa credo che la ingoierò giù, la masticherò ben bene, penserò ai tuoi occhi di cioccolata liquida e mi sentirò a casa, anche se tu non ci sarai.
Non è più tempo di mettersi sulla strada.
Un po' alla volta, quasi in punta di piedi, stanca di un mondo che ha smesso di ascoltarla, la "beat generation" si sta trasferendo in un'altra dimensione, o comunque si voglia definire il mistero dell'al di là. Domenica sera, in una clinica del Vermont, se n'è andato Peter Orlovsky, che unì il suo nome a quello di Jack Kerouac, di William Burroughs, di Gregory Corso e degli altri protagonisti della grande stagione della controcultura americana. Ma che, nella vicenda dei "battuti e beati", resterà per sempre come colui che fuse il suo percorso esistenziale e poetico con quello del più grande esponente del movimento letterario che sconvolse l'America tra anni 50 e 60, Allen Ginsberg, l'autore dell'Urlo.
I beat se ne vanno, uno dopo l'altro.
Cose che accadono, reimpasto generazionale.
Quello che mi spaventa è che molti dei loro posti rimarranno vuoti.
Questa generazione non sa come rispondere.
Non ha nessuno da mandare in prima linea.
Perciò manda tutti nella bocca del leone.
Ecco, sì, questa è roba che mi spaventa.
Muore l'amore beat di Ginsberg.
I beat se ne vanno, uno dopo l'altro.
Cose che accadono, reimpasto generazionale.
Quello che mi spaventa è che molti dei loro posti rimarranno vuoti.
Questa generazione non sa come rispondere.
Non ha nessuno da mandare in prima linea.
Perciò manda tutti nella bocca del leone.
Ecco, sì, questa è roba che mi spaventa.
Muore l'amore beat di Ginsberg.
[Nati di traverso.]
Roba vecchia, ma tocca fare ordine.
Giulia Guida recensisce "I cariolanti" di Sacha Naspini per Liberi di Scrivere.
Non ci si lava dal sangue, in nessun modo, neanche la morte può essere la grande consolatrice di sempre. Non ci sono punti di fuga, l'immagine è la stessa, ripetuta fino all'ossessione. Alcuni elementi fanno come parte di un substrato mitico, si ricoprono di significati simbolici e rimandano alla dimensione del primitivo, privo di coordinate spazio-temporali ben definite. Il percorso che compie Bastiano lungo l'arco della sua vita può essere letto come un rito di passaggio attraverso il buio, il bosco, il silenzio, la terra madre che protegge e che divora ed un eterno ritorno a un destino da nati di traverso.
Nascere di traverso.
martedì 1 giugno 2010
[Amnesiac.]
Mettere Amnesiac in repeat non è mai un buon segno.
Ma tant'è, oggi è l'unica cosa che riesco ad ascoltare senza dover ricordare.
Anestesia totale.
Mi abbraccio ad un incubo.
Sono solo nove secondi.
Poi mi sveglio. Ecco. Poi mi sveglio.
E il cielo fuori è precipitato giù.
Senza più coperte.
Sono sotto una grandine nera che ringhia contro l'asfalto.
E mi lascio colpire. E mi lascio ferire. E mi lascio dimenticare.
Reparto anestesie, piano terra.
Carta da macero. That's it.

Nel 2009 non c’è stato che un piccolo rallentamento nella produzione di libri in Italia. La media adesso è di 170 titoli al giorno. Nel 2008 i libri usciti erano stati 65.000, con una media di 180 al giorno. Ma alcuni settori sono già di nuovo in aumento, come la religione, su cui puntano anche gli editori laici. Gli editori piccoli sono quelli che pubblicano da 1 a 10 libri l’anno, i medi da 11 a 50, i grandi oltre 50. La media dei grandi editori, o grossi editori, come Mondadori, Rizzoli, Gems, e i vari marchi che comprendono, è di 250 titoli l’anno. In Italia ogni libreria ha in media un “giro” del 35-40 per cento di titoli che non vendono nemmeno una copia. La maggior parte hanno una vita media di 50-60 giorni, dopodiché vengono restituiti. Gli altri vendono perlopiù nel primo anno, oppure mai più. Pochissimi resistono e diventano best seller. Nel 2009 in tutte le librerie Feltrinelli ci sono stati 131.000 titoli che hanno venduto ciascuno meno di 10 copie. In Italia abbiamo 691 comuni oltre i 10.000 abitanti dove non c’è nemmeno una libreria. In certe zone del Paese si possono percorrere anche 200 chilometri senza trovarne una. Si tratta di 12 milioni di persone che praticamente non hanno la possibilità di acquistare libri, se non spostandosi o procurandoseli via internet. È come una linea ferroviaria Freccia Rossa, Milano-Roma, senza fermate intermedie.
(Quanto sopra è un sunto da un articolo uscito su ”Libero” nel marzo 2010 sulla base di un sondaggio effettuato da un istituto di ricerche)
"Istruzioni per un addio". [Reminder.]
Iscriviti a:
Commenti (Atom)